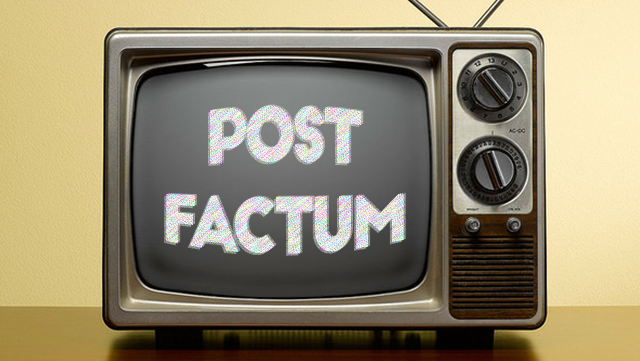La7, proprietà di Urbano Cairo, è spesso accusata di civettare, e qualcosa di più, con il grillismo, il salvinismo e l’anticastismo. In poche parole, di essere pappa e ciccia col populismo. Lo stesso Cairo, sul Foglio di oggi, declina l’accusa di deliberata connivenza e, citando un recente Santoro, rovescia la questione mettendola su un piano strutturale: «La tv vive spesso di contraddittori e per questo a volte può capitare di veicolare un messaggio che si sovrappone con quello di forze politiche che si trovano all’opposizione. Ma non significa essere a favore di qualcuno o contro qualcuno… Non è grillismo, ma un modo di fare giornalismo». In effetti il rapporto del pubblico con la televisione è fuggevole e distratto sicché i programmi di informazione, stretti fra la concorrenza degli altri canali, le distrazioni a casa dello spettatore e mille altri disturbi, per farsi notare in mezzo a tanto frastuono devono spararle grosse e, principalmente, nitide come solo la contraddizione può fornire: non solo quella della disputa, ma più in generale quella espressa dalle ferite, e non certo dalle giunture, della realtà.
Quindi è la struttura stessa del rapporto con il loro pubblico di per sé erratico che rende i talk show disruptive anzi che constructive. E se mai la tv possa contribuire a placare le ansie anziché camparci sopra, questo compito è più alla portata della fiction, perché la curiosità di seguire lo svolgersi del plot inchioda, bene o male, gli spettatori al programma (la permanenza d’ascolto delle “storie” è quattro volte superiore a quella riscossa dai talk). Però, messe così le cose, tocca farsi venire il dubbio che i talk show siano “corrosivi della democrazia” perché ne esacerbano i limiti, esattamente come lo stesso Zuckerberg ha cominciato a congetturare riguardo ai social network, in quanto temprano narcisismo e bolle tribali anziché temperarli.
In entrambi i casi il problema nasce dalle condizioni strutturali (della tv e dei social) e nulla potrebbero nuove iniziative di comunicazione “di qualità”. Ben vengano, ovviamente, ma la disarticolazione della comunicazione sociale, e quindi della democrazia, accentuata dai social resterebbe comunque intatta. Per esempio, noi ci dilettiamo ogni mattina con le lettura del New York Times on line. Per restare meglio immuni da Di Battista e Salvini (e compagnia) grazie a una fonte in cui rispecchiarci. E così viviamo felici senza talk e senza troll, mentre i tweet difformi li leggiamo solo per dargli addosso, cioè per dare meglio ragione a noi stessi. Resta la questione della democrazia liberale (altre non ce n’è), quella dove le teste si contano e non si rompono (né si recingono in reciproci apartheid). Di cosa può vivere se non può fare conto – come al tempo che fu – sui media? Ovviamente di relazioni corte: vicinato, territorio, luoghi di lavoro. In una parola, alimentandosi di rapporti diretti, gli unici in grado di corrodere, essi sì, le appartenenze a cui siamo altrimenti e fatalmente aggrappati.
Certo, servirebbe che oltre alle ricorrenti nuove politiche ci fosse anche un “partito nuovo” che la democrazia pensasse a costruirla oltre che sguazzarci dentro per quel che ce n’è. Ma, perbacco, un partito – specie se “nuovo” per struttura e cultura – lo puoi concepire solo entro una visione di Stato, Sovrastato e Mondo. Vasto programma. Nel frattempo, clicchiamo su Nyt.